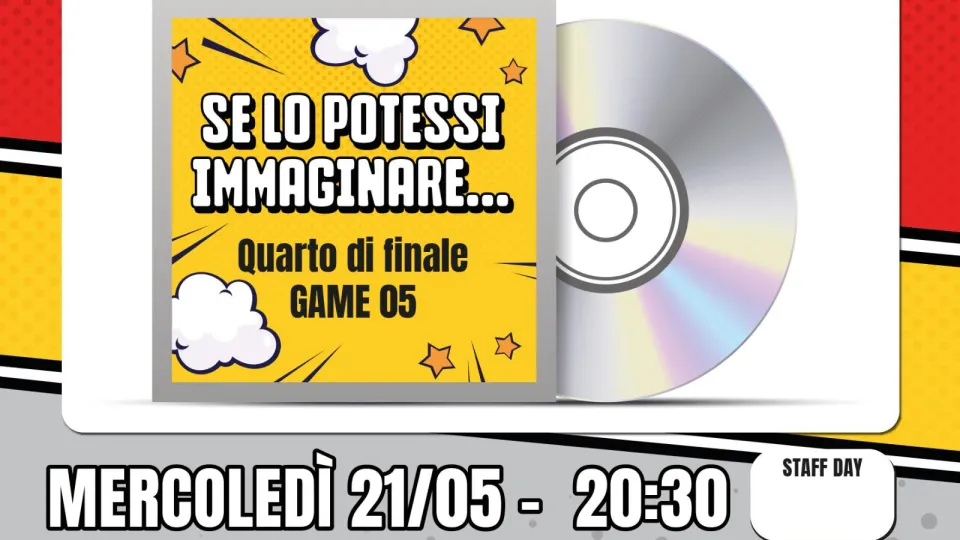La meraviglia che passione

Sabato 9 novembre si è tenuto il terzo appuntamento con “Biblioterapia”:come curarsi (o ammalarsi) coi libri”, a cura della Biblioteca Gambalunga, con il contributo della Provincia di Rimini e il patrocinio dell’IBC. Quest’ anno il ciclo di incontri dedica le sue conversazioni e letture ad alta voce a indagare la meraviglia, secondo Cartesio la “prima delle passioni”.
Relatore di questo incontro è Vito Mancuso già docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Da marzo 2013 docente di “Storia delle dottrine Teologiche” presso l’Università degli Studi di Padova. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino (Raffaello Cortina, 2007) e Io e Dio Una guida dei perplessi, (Garzanti, 2011). Dal 2009 è editorialista di “la Repubblica”. Il suo ultimo libro è Il principio passione. La forza che ci spinge ad amare (Garzanti, settembre 2013).
A lui è affidato il tema Meraviglia o Dolore? Al principio del pensiero.
“Conosci te stesso” e “nulla di troppo” scrivevano gli antichi nel tempio dell’Oracolo di Delfi: conosci chi sei e non presumere di essere di più. Ma nello stesso tempio c’è anche un’altra iscrizione, una “E” dal significato controverso. Alcuni grecisti la associano al verbo per eccellenza (essere) che rimanda al mistero dell’essere al mondo.
Da qui parte la riflessione di Mancuso: questo essere (al mondo) fa scaturire più meraviglia o dolore? Cosa maggiormente sprona il nostro pensiero il lato oscuro o il lato luminoso?
Considerando i diversi significati della parola pensare in varie lingue si possono ritrovare i le origini della concezione di pensiero nelle diverse culture.
L’italiano lo fa derivare da pesare, soppesare. La mente è vista come una bilancia con tutte le implicazioni che ne derivano: il pensiero è pesante, serve un contrappeso perché esista ecc…
In latino cogitare. Agitare insieme: è necessario saper cogliere le polarità, le devi agitare per metterle in relazione l’una con le altre per poter pensare. E’ un’esortazione ad aprirsi al diverso e al contraddittorio.
Per i greci idea deriva da idein, vedere. Il pensare nasce dallo sguardo, dalla retta visione. Pensa chi sa vedere e così facendo libera l’idea.
Per tedeschi e inglesi il pensiero è ringraziamento, meraviglia. Denken e think, il pensare derivano da danke e tanks, il ringraziare. E’ tipico anche del filosofo essere pieno di meraviglia.
Il pensiero nasce quindi dalla meraviglia e dalla “agitazione”. Meraviglia e dolore entrambe le cose sono necessarie al pensiero. Nella tradizione letteraria il dolore può essere testimoniato da Baudelaire: la vita come ospedale e malattia, senza questo senso di dissidio, malattia, solitudine per lui non c’è pensiero. Rivolgendoci anche ad esperienze più vicine a noi anche i ragazzi adolescenti cominciano a diventare grandi quando cominciano a dire no, ad essere insoddisfatti.
Ma non basta: fermarsi a questo porta ad un pensiero sterile e immaturo che si limita all’opposizione. Manca la dimensione del denken, della meraviglia che può essere testimoniata da Paul Davies (astrofisico britannico). Egli parla di particelle subatomiche, onde gravitazionali, buchi neri, ma per quanto stupefacente tutto ciò, il fenomeno della vita per lui è estremamente più stupefacente. La vita è nata da un jackpot cosmico: le probabilità contrarie alla formazione delle proteine (i mattoni della vita) sono rappresentate da un numero che occuperebbe le pagine di un capitolo di un libro. Le stesse probabilità che una tromba d’aria spazzando un robivecchi produca un Boing 747.
Mancuso afferma che al principio del pensiero c’è quindi una antinomia: mondo come ospedale (dolore) ma anche come cattedrale (meraviglia). Ci sono due leggi che prescrivono cose opposte, la conseguenza è che non esiste nessun pensiero o dottrina che spieghi integralmente la vita. La vita non è catturabile, per questo è richiesta la fede. La vita impastata di meraviglia e dolore richiede la nostra fiducia perchè il pensiero ti inchioda al dubbio, al mistero.
Se il sapere potesse spiegare tutto non ci sarebbero le religioni e le filosofie. Il senso del pensare è quello di mettere al cospetto del flusso della vita. La sua finalità non deve essere la coerenza fine a se stessa che sviluppa un pensiero chiuso (credenza o ideologia): il vero pensiero produce un sistema aperto.
Wiliam Zavoli