Insediamento nuovo Vescovo. La prima Omelia e il messaggio alla Chiesa
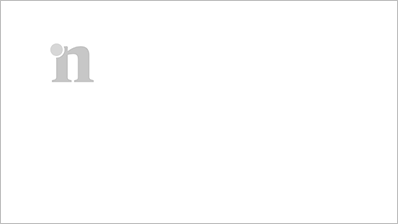
L’omelia
“Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero” (1Tm 1,12). Permettetemi, carissimi, di applicare a me stasera le parole dell’apostolo Paolo, che abbiamo appena ascoltato. Con s. Agostino posso dire in tutta sincerità e semplicità: “Oggi voi mi vedete qui vostro vescovo per divina volontà”, ma “non ho cercato io il grado in cui mi trovo qui” (Disc. 335,2). Se ora mi è dato di cominciare a servire questa vostra, ormai “nostra” amata diocesi, non è né per meriti che io non ho acquisito né per un premio che non ho conquistato: è solo per un misterioso disegno della divina misericordia. Sì, misericordia è l’unica parola che stasera può essere detta da me, e anche da voi può essere detta di me, e come s. Paolo io non posso che esserne letteralmente sorpreso e stupito. Anch’io infatti “ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me, per primo, tutta la sua misericordia” (II Lett.).
1. “Misericordia” è anche la parola che concentra il succo del santo evangelo che ci è stato appena proclamato. Se rileggiamo le tre parabole non in successione, ma in parallelo, cogliamo un messaggio in progress, che non possiamo non accogliere stupefatti e commossi. Ricordiamo il contesto storico, descritto da s. Luca: gli avversari avevano criticato Gesù “perché “riceveva i peccatori e mangiava con loro”. Non avevano criticato Dio, eppure Gesù si difende chiamando in causa proprio il Padre. Come mai? Tale replica sarebbe incongrua se non presupponesse, pur senza formularla esplicitamente, l’irrefragabile consapevolezza da parte di Gesù che Dio agisce qui e ora attraverso di lui: nelle parole e nei gesti del Figlio è il Padre stesso che si mette a cercare i suoi figli perduti.
“Mostrami, Signore, il tuo volto”: era stata la preghiera ardente di Giacobbe-Israele, di Mosè, di Davide, di Elia. “Il tuo volto, Signore, io cerco; non nascondermi il tuo volto”: questo è stato il sospiro vibrante di tanti e tanti giusti di Israele, da Abramo alla sua discendenza, fino a Giovanni il Precursore e a Maria di Nazaret, fino a Pietro e a Filippo di Betsaida, fino a Paolo di Tarso.
Ed ecco la risposta di Gesù alla fame di Dio che tormenta da sempre il cuore dell’uomo: “In verità vi dico, in verità ve lo dico io come è fatto il volto di Dio. E’ come il volto di un pastore tenero e premuroso, di una casalinga accorta e generosa, di un padre irriducibilmente misericordioso”. Tre immagini per scolpire un solo volto: il volto del Dio, ricco di bontà e di tenerezza. Se la prima immagine – il pastore – è quella di un uomo, la seconda – sorprendente per i suoi uditori, e anche per noi se non ci siamo assuefatti – è quella di una donna. Arrivato alla terza immagine, Gesù fa sintesi tra le prime due: mette insieme i tratti maschili del pastore e quelli femminili della casalinga, e ci pennella il volto di un padre buono con il cuore dolcissimo di una madre.
E’ veramente un cuore materno quello del padre della parabola: “quando (il figlio) era ancora lontano, lo vide e si commosse”. L’abbinamento di questi due verbi – vedere e commuoversi – è molto caro all’evangelista Luca, che vi aveva già fatto ricorso per descrivere l’approccio di Gesù nei confronti della vedova di Nain, nel momento in cui veniva portato alla sepoltura l’unico figlio, prematuramente scomparso: il Signore “la vide e si commosse” (Lc 7,13). La seconda volta questi verbi ricorrono appaiati nella parabola del buon Samaritano, e sono due dei dieci verbi usati per descrivere il soccorso da lui prestato a quel povero malcapitato, che era stato lasciato mezzo morto lungo la Gerusalemme-Gerico. Da notare che l’accento cade ogni volta sul secondo verbo – commuoversi – un verbo tipicamente materno, perché indica il sobbalzo del grembo quando la mamma si vede correre il figlio incontro: è appunto da quel brivido viscerale che si sente afferrato il padre misericordioso quando vede il figlio vagabondo, ancora lontano.
Così Gesù vede i suoi fratelli peccatori: li vede con gli occhi del cuore benevolo e compassionevole del Padre. Davvero “non si vede bene che col cuore; l’essenziale è invisibile agli occhi” (Saint-Exupéry).
Questa è la fotografia fedelissima, al più alto grado di risoluzione, del Dio “ricco di misericordia”, siglata da Gesù, il Figlio, che davvero è … tutto suo Padre! Essere onnipotente e accettare che il figlio minore se ne vada di casa, per accoglierlo poi a braccia aperte quando ritorna; lasciar perdere tutto e andare a cercare la pecora smarrita; essere padrone di ogni cosa e mettersi a servire i propri servi: questo modo divino e umanissimo di comportarsi si chiama misericordia.
2. Ma se ci fermassimo a questo punto, rischieremmo di fare di questo evangelo una lettura “datata”, storicamente fedele al suo originario contesto pre-pasquale – capace al più di darci una sorta di “Gesù fossile” – ma non una lettura “nello Spirito”, possibile solo alla luce della Pasqua, il vertice e compimento di tutta la storia di Gesù. L’evento capitale della morte e resurrezione infatti è la definitiva soluzione dell’enigma-Gesù, e quindi la completa risoluzione degli enigmi di Gesù, quali sono le sue parabole. La Pasqua – come rivelazione piena e definitiva della misericordia del Padre – richiede pertanto e insieme permette, anzi favorisce una reinterpretazione delle nostre tre parabole. Senza l’evangelo della misericordia la Pasqua sarebbe muta; senza la Pasqua l’evangelo della misericordia sarebbe morto: infatti senza la risurrezione, ogni parola di Gesù sprofonda nel nulla, soccombe al giudizio inappellabile del tempo e diventa fatalmente “lettera morta”. Dissociate dalla risurrezione, anche le parabole di Gesù diventerebbero “soltanto parabole”, come quelle dei saggi di cui parlava Kafka. E ad una parabola religiosa o cristiana se ne potrà sempre contrapporre una atea, per esempio a quella del figlio perduto una parabola del padre perduto: si pensi ai rifacimenti di D’Annunzio o di Gide.
Dobbiamo perciò chiederci: qual è il valore aggiunto, il fascio di luce che la Pasqua proietta sulla parabola del padre misericordioso e ne consente finalmente una piena comprensione? Forse potremmo ricostruire la parabola così. In un tempo senza tempo – senza né prima né dopo, senza né passato né futuro, senza ore né minuti né secondi e senza neanche millesimi di secondo – Dio ha generato, nello Spirito Santo, il Figlio del suo amore.
Da sempre il Padre ama il Figlio e gli mette tutto nelle mani: il Padre è il massimo dare, senza trattenere nulla per sé; e il Figlio riceve tutto e, senza trattenere nulla per sé, ridona tutto al Padre. Il Padre è la massima gratuità; il Figlio la massima gratitudine. La felicità del Padre e del Figlio per questo reciproco, irreversibile donarsi ha il volto e il nome benedetto dello Spirito Santo. Questa felicità divina, senza macchia e senza ombra, neanche Dio la può aumentare – perché ad essa non si potrebbe aggiungere neppure un atomo in più di ulteriore felicità – ma Egli la vuole liberamente condividere con noi. Ecco la creazione: “la chiave dell’amore aprì la mano di Dio – afferma s. Tommaso – e ne uscirono le creature”. Per amore, solo per nostro amore, Dio ci ha creati: “per il desiderio di farci felici” (Ps. Barnaba).
Ma poi sappiamo come è andata avanti la storia. Il padre della menzogna, il serpente antico, ha contagiato il cuore dell’uomo con il virus del sospetto contro Dio, il quale sarebbe morbosamente geloso della sua gloria, e si sarebbe implacabilmente accanito, per invidia, contro la nostra felicità: vedi il dramma del peccato originale. Le cose invece stanno esattamente al contrario. Radice del peccato è la cattiva opinione sul Padre, comune sia al figlio minore che al maggiore. L’uno, per liberarsene, instaura la “strategia del piacere” che lo porta ad allontanarsi di casa. L’altro, per monopolizzarne la benevolenza, instaura la “strategia del dovere”, con una religiosità servile, che sacrifica la gioia del vivere. Ambedue hanno l’idea di un padre-padrone, che – qualcuno ha detto – se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo, per tenere schiavi gli uomini (Voltaire); e se ci fosse, bisognerebbe distruggerlo, per poterli liberare dal suo giogo insopportabile (Bakunin).
Ma quanto più i figli si sono messi contro il Padre, tanto più Dio ha amato il mondo, fino al punto da mandare a noi nella pienezza dei tempi il suo unico Figlio come salvatore. “Ma che cosa ha portato Gesù veramente – si chiede papa Benedetto nel suo ultimo libro su Gesù di Nazaret – se non ha portato la pace nel mondo, il benessere per tutti, un mondo migliore? Che cosa ha portato? La risposta è molto semplice: Dio. Gesù ha portato Dio. Ora noi conosciamo il suo volto, ora noi possiamo invocarlo. Ora conosciamo la strada che, come uomini, dobbiamo prendere in questo mondo. Gesù ha portato Dio e con Lui la verità sul nostro destino e la nostra provenienza: la fede, la speranza e l’amore”.
Alla luce della Pasqua, siamo così in grado di decifrare fedelmente e compiutamente l’evangelo della misericordia. E’ Gesù il Figlio, che letteralmente “era morto ed è tornato in vita”; è lui il pastore buono che si era perduto dietro i peccatori per cercare le pecore perdute del gregge di Dio; è lui il Figlio prediletto del Padre che ha preferito perdere la sua vita per salvare la nostra. E’ lui il vero “figlio prodigo”, che non ha dilapidato i beni del Padre per capriccio, ma si è “prodigato” per amore nostro, e “da ricco che era si è fatto povero per noi, per arricchirci con la sua povertà” (cfr. 2Cor 8,9). E’ lui il vero figlio maggiore, il primogenito di molti figli, che “non si vergogna di chiamarci fratelli”, noi che lo abbiamo tradito, venduto e ucciso (cfr. Eb 2,11).
A questo punto non ci resta che il grido di stupore grato e ammirato che s. Agostino formulava così: “Quanto ci hai amati, Padre buono, quanto ci hai amati, Tu che non hai risparmiato tuo Figlio, ma lo hai dato per noi peccatori!” (Conf. 10,43).
3. Prima di concludere, permettetemi di raccogliere due domande e di formulare una preghiera, che poi dovremo far risuonare nel nostro cuore e prolungare nelle nostre comunità.
Sono diversi secoli – almeno diciassette, se non diciotto – che nella nostra Chiesa è stato acceso il fuoco dell’evangelo pasquale della misericordia del Signore morto e risorto. Ma in quante comunità e da parte di quanti, che pure si professano cristiani, si conduce una vita come se Cristo non fosse veramente morto per i nostri peccati e non fosse realmente risorto per salvarci? Cosa dobbiamo confermare e cosa innovare, cosa dobbiamo “convertire” perché l’annuncio evangelico che risuona nelle nostre chiese perda la sua patina di cosa trita e ritrita e ritrovi la sua nota inconfondibile di “lieta notizia” dell’ultima ora?
Inoltre, se è vero che solo la misericordia è credibile, allora soltanto una Chiesa che sia autentica “casa della misericordia” ha le carte in regola per annunciare la rivelazione del Dio “Padre di ogni misericordia”. Grazie a Dio e per nostra buona fortuna, questa Chiesa non nasce oggi: essa è stata fecondata con il sangue dei martiri, è stata impreziosita con la santità di testimoni eroici – da s. Gaudenzo ad Alberto Marvelli – è stata paternamente guidata e felicemente introdotta nel terzo Millennio dal mio amatissimo predecessore, il vescovo Mariano, con la collaborazione infaticabile di questo presbiterio, di tante zelanti religiose e religiosi, di tantissimi laici, aggregati o non, uomini e donne, che hanno amato e amano questa Chiesa come la loro famiglia… Noi vogliamo continuare su questa strada, e perciò rinnoviamo l’impegno di andare incontro ai tanti che si sentono o sono “figli prodighi” – soprattutto a quelli che lo fossero per colpa nostra. Noi crediamo che anche loro sono nostri fratelli, e crediamo pure che l’evangelo della misericordia ci richiede di usare per loro la misericordia dell’evangelo. E dunque quali scelte precise, quali passi concreti ci sono richiesti – è la seconda domanda – perché la Chiesa di Rimini sia e venga vista come una casa abitabile da tutti gli smarriti di cuore, perché sia e venga frequentata come una vera casa della divina misericordia?
Infine l’impegno, che riguarda innanzitutto me. Il vescovo – voi lo sapete – è il sacramento, il segno-strumento della misericordia di Cristo Pastore. Ma è pure il segno che rende visibile ed efficace la misericordia di Dio Padre per i suoi figli, per una determinata porzione della sua santa famiglia che vive in un determinato territorio. Permettetemi allora di esortarvi con le parole di un vescovo molto più santo e sapiente di me, s. Ignazio di Antiochia: “Considerate nel vescovo l’autorità che gli è stata conferita da Dio Padre. Vedete in lui non la sua persona, ma il Padre di Gesù Cristo, vescovo di tutti” (Magn. 1,1).
Ora, mentre io mi assumo l’impegno di tendere a questo ideale, voi pregate per me, perché sia fedele a questo impegno fino all’ultimo giorno che l’altissimo, onnipotente e buon Signore vorrà concedermi.
“Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen”.
Messaggio del Vescovo Francesco Lambiasi alla Chiesa diocesana di Rimini
SOGNO LA CHIESA DAI CINQUE TALENTI
Con questo messaggio desidero stabilire un primo contatto con il maggior numero possibile di voi, carissimi, un contatto che quanto prima spero possa raggiungere tutti i fratelli e le sorelle, come pure le donne e gli uomini di buona volontà che vivono e operano in questa terra incantevole, percorsa da generosi fermenti di bene, ma anche attraversata da rischi e problemi.
Mentre mi andavo preparando a questo giorno, mi è più volte tornata alla mente una immagine, tratta dagli Atti degli apostoli. Nell’autunno dell’anno 60 dopo Cristo, su una grande nave, in rotta verso l’Italia, si trovavano 276 persone, digiune da due settimane a causa di una violenta tempesta che rischiava di tramutarsi in un drammatico naufragio. Tra i passeggeri c’era Paolo di Tarso, condotto in catene da Antiochia a Roma per essere giudicato dal tribunale imperiale cui si era appellato. L’apostolo, dopo aver invitato gli altri a prendere il cibo, necessario per garantire una possibilità di sopravvivenza, “prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch’essi presero cibo” (At 27,33-36). In un contesto di drammatica emergenza i cristiani, nella stessa barca degli altri, solidali nel pericolo comune, spezzano il pane della salvezza: non è questa una suggestiva immagine della nostra Chiesa?
Su quella nave che rischia la deriva Paolo è l’uomo più povero – è privo perfino del bene fondamentale della libertà – ma si porta in cuore un tesoro prezioso, fatto di cinque “talenti”. Sono i doni inestimabili del nostro battesimo, che vengo a condividere con voi.
Il primo talento è lo splendore della verità. Per s. Paolo la verità non è una formula complicata o un argomento più o meno ghiotto da talk-show né una utopia vaga e vaporosa; non è neanche una grande idea astratta e lontana: è una storia, anzi una persona, quel Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto da cui l’apostolo è stato irresistibilmente attratto e da cui si sente immeritatamente amato. Per Paolo, Gesù non è un personaggio leggendario, avvolto dalle nebbie del mito, né un grande eroe del passato: è una persona, che egli sperimenta talmente viva, da fargli dire: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, Lui che mi ha amato e ha voluto morire per me”.
E’ vero: quando tu, fratello, sorella, ti lasci afferrare da Lui, la vita cambia e diventa “cristiana”, a misura di Cristo: riesci, per suo dono, a vedere la storia e il mondo come Lui, ad amare e a perdonare come Lui, a sperare come insegna Lui, in una parola ti è dato di vivere come Lui, con Lui, di Lui.
Allora si sente che il grande sogno che ci portiamo in cuore come un “marchio di fabbrica” – il sogno di una felicità infinita, perfetta, incontaminata, senza più lutto né dolore né pianto – non è un miraggio disperante. E si tocca con mano che è possibile vincere la madre di tutte le paure, quella della morte, perché Cristo non è spirato tranquillamente nel suo letto: è stato trucidato come un martire, ma è risorto e ha aperto una falla nel muro nero della morte, attraverso cui tutti ormai possiamo passare per approdare alla sponda “che solo amore e luce ha per confine”.
Il secondo talento è il pane dell’eucaristia. E’ interessante notare che, in quella pagina drammatica degli Atti, s. Paolo pone lo stesso gesto che Gesù fece nell’ultima cena: prese il pane, rese grazie a Dio Padre, lo spezzò, lo diede…
Anche il contesto in cui viviamo – non ce lo possiamo nascondere – è delicato e drammatico: la nostra cultura marcatamente individualista è segnata da un edonismo ossessivo che ha eretto il piacere a idolatria, mettendo a repentaglio quei grandi valori umani così cari alla nostra terra, come l’accoglienza e il rispetto, l’impegno e la fiducia. Questo accanimento edonistico – il piacere sempre e comunque – crea un mare di sofferenze, con i tristi fenomeni delle famiglie disgregate, dei coniugi abbandonati, dei figli contesi o lasciati soli, e con offese sempre più gravi alla dignità della persona. Aggiungiamo poi tutti i problemi e i drammi generati da un materialismo economicista sempre più sfrontato e aggressivo; assommiamo le enormi ingiustizie e violenze prodotte nella vita dei singoli e dei gruppi da una concezione della libertà svincolata dalla verità e da ogni norma morale. Sono problemi planetari, che la globalizzazione ingigantisce a dismisura, ma hanno una pesante ricaduta nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nelle nostre parrocchie. Madre Teresa osservava: “La gente è affamata d’amore, perché siamo tutti troppo indaffarati”.
Cosa possiamo fare noi? I lamenti sterili non servono, i proclami retorici non risolvono. L’eucaristia è la nostra straordinaria, insostituibile risorsa: non ci aliena dal mondo, ma ci immerge in esso con l’energia dell’amore e ci abilita a trasformare il creato e la storia in segni efficaci del futuro del mondo. Partecipare alla mensa della parola e del corpo di Cristo significa assimilare la sua vita, entrare nella sua logica, che non è una logica di accaparramento – ognuno per sé – o di quantità: ci vogliono tanti soldi… La logica di Gesù è la logica della gratuità, della condivisione totale: è la logica dell’amore. “Fare la comunione” significa la grazia e l’impegno a “fare comunione”.
Tutti siamo abbastanza poveri per dover ricevere, tutti abbastanza ricchi per poter dare: abbiamo qualche ora di tempo da offrire, qualche competenza da mettere a disposizione, almeno un sorriso o un gesto di consolazione o di perdono da donare. Insomma chi di noi non ha i suoi “cinque pani e due pesci”? Se siamo disposti a metterli nelle mani del Signore, basteranno e avanzeranno perché nel nostro angolo di mondo ci sia un po’ più di fraternità, di pace, di giustizia e, perché no? un po’ più di gioia.
Il terzo talento di Paolo e di ogni cristiano è il dono della Chiesa. E’ usuale raffigurare la comunità cristiana nell’immagine della barca o della navicella di Pietro. Viaggiando in Italia e all’estero in questi anni, mi sono sempre più convinto che è ormai giunto al capolinea il cristianesimo dell’abitudine e della convenzione e sta rinascendo il cristianesimo della convinzione e della scelta, il cristianesimo dell’innamoramento. Oggi scegliere Cristo è tornato a costare, ma è possibile compiere questa scelta solo per amore. O la fede è un vero, grande amore per Cristo o non è fede vera. Se è tale, allora non si può dividere ciò che Dio ha unito, Cristo e la sua Sposa: la Chiesa.
Noi amiamo questa Chiesa, che nonostante le sue rughe, è stata per noi la madre che ci ha generato alla fede. Con una madre non ci si può mai sentire in credito: noi sappiamo che senza la Chiesa, non avremmo incontrato Gesù Cristo; sappiamo pure che nella barca di Pietro ci stiamo non per salvarla dal naufragio, ma per esserne salvati. E in questa barca ci restiamo ricordando che – come vi ha più volte ricordato il mio caro predecessore – nella Chiesa c’è posto per tutti, ma tutti devono stare al loro posto. Personalmente mi piace esprimere questa stessa convinzione con l’immagine del coro: ognuno canta con il suo timbro di voce personale e inconfondibile, ma tutti sono impegnati ad eseguire lo stesso spartito, quello del vangelo. In questo coro il vescovo è come il maestro che “dirige” il canto, valorizzando ogni voce e aiutando tutti a fare coro. Al riguardo mi capita, e mi capiterà forse anche con voi, di dire che nella Diocesi solo io sono il vescovo – non per mio merito, ma per pura grazia – ma io sono… solo il vescovo: devo quindi aiutarvi ad evitare che ognuno voglia essere il tutto, ma so che voi pure mi aiuterete perché io non mi accrediti come il tutto della nostra Chiesa.
Cerchiamo tutti insieme di fare coro!
Il quarto talento che ci è stato donato al battesimo è la croce. Paolo incatenato sulla nave rassomiglia tanto al suo Signore crocifisso. Ma davvero la croce è un dono? No, secondo la mentalità corrente che punta sul trinomio “avere-potere-piacere”. Per molti oggi la croce non è più una bella notizia, perché è stata staccata da Gesù, e allora non viene più vista come dono e amore, bensì come dolore, pena e tristezza. Ma è Gesù che dà senso alla croce, non il contrario!
Alla scuola del nostro unico Maestro crocifisso, la croce non appare più come la negazione dell’umano: è piuttosto il suo inimmaginabile compimento. La croce non è il segno meno (-) che negativizza gli autentici valori umani, ma il segno più (+) che li afferma e li innalza all’ennesima potenza. Il cristianesimo è la religione del “grande sì”: niente di ciò che è umano è estraneo al cristiano. La fede non uccide l’intelligenza: la tiene in vita. Il vangelo non inibisce l’affettività, la sessualità: le mantiene in quota. Il divino non boccia l’umano e non lo schiaccia: lo promuove e lo esalta. Non è vero che la povertà evangelica fa godere di meno; piuttosto fa godere di più perché ci distacca dalla frenesia e dall’ingordigia: è la possessività vorace e insaziabile che sciupa le cose e le guasta. Non è vero che la castità cristiana fa amare di meno, semmai fa amare di più, perché sana in radice la nostra voglia malsana di possedere e di usare l’altro. Infatti o sulla croce ci inchiodo il mio io malato ed egoista o prima o poi ci crocifiggo qualche altro…
E per finire, non possiamo non immaginare Paolo felice, per quanto incatenato e ormai prossimo al martirio: ecco il quinto talento del cristiano, la gioia. Se è vero – come ci ha detto Gesù – che “non c’è amore più grande del donare la propria vita per amore” e che “c’è più gioia nel donare che nel ricevere”, allora è vero che la gioia più grande abita in… via della croce. La croce infatti sta a dire fino a che punto il Padre di Gesù si è compromesso con il nostro dolore: fino al punto da darci il suo bene più caro, la vita di suo Figlio. E questo Figlio è venuto in mezzo a noi non per tenerci un corso sulla sofferenza, ma per fare della sofferenza il percorso dell’amore. Cristo in croce ci dice che Dio non sempre ci libera dal male, ma ci libera sempre nel male. E quando non può esaudire i nostri desideri, non manca però mai di realizzare le sue promesse.
Senza ovviamente cadere in posizioni terreniste e senza dimenticare la smisurata differenza qualitativa tra la vita presente e quella futura, dobbiamo credere che la gioia, per il cristiano, non si colloca solo oltre il dolore, e cioè oltre questa “valle di lacrime”, ma è possibile già quaggiù, insieme al dolore, quando questo viene vissuto nella fede e nell’abbandono all’amore invincibile di Dio e nella condivisione del dolore di quanti soffrono più di noi: questa è l’esperienza della perfetta letizia, insegnataci da santa Maria di Nazaret, “la faccia che a Cristo più si somiglia” (Dante) e fedelmente vissuta da Francesco d’Assisi.
Permettetemi ora di formulare alcuni brevi messaggi di saluto.
Innanzitutto desidero rinnovare la gratitudine al mio predecessore, il carissimo Vescovo Mariano: che il Signore lo ripaghi del grande bene che ci ha fatto, e lo rimeriti per ciò che è stato e continuerà ad essere per la nostra Diocesi. Il suo esempio e la sua preghiera ci saranno di grandissimo aiuto.
Nel momento di lasciare l’incarico di Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana, ripenso con affetto memore e grato alle tante persone, associazioni e gruppi incontrati in molte parti d’Italia; ai carissimi Assistenti centrali; ai membri della Presidenza Bignardi e dell’attuale Presidenza Alici; ai collaboratori del Centro Nazionale.
Saluto di cuore tutti e singoli i confratelli Sacerdoti della Diocesi, ringraziandoli per la passione che mettono e metteranno nell’edificare l’unico presbiterio, e insieme a loro mi fa molto piacere salutare con affetto il collegio dei Diaconi e, con particolare predilezione, i nostri carissimi Seminaristi.
Ai Responsabili della cosa pubblica e ai Rappresentanti dei vari settori della vita sociale desidero assicurare la mia stima rispettosa, nella fiducia di una stretta collaborazione per il bene comune.
Un particolare pensiero riconoscente e colmo di speranza sento di dedicarlo ai Religiosi e alle tante Religiose, con la preghiera ai nostri patroni e ai loro santi fondatori perché li aiutino a profumare di santità e di perfetta letizia la nostra Diocesi, sull’esempio dell’ultima Beata di questa bella Chiesa riminese, Sr. Bruna Pellesi.
Alle Sorelle e ai Fratelli poveri, infermi e sofferenti, insieme al grazie per la fede e per l’esempio che ci danno, formulo l’augurio di essere per tutti noi l’“avanguardia” orante e la più sensibile antenna ricetrasmittente dei messaggi dalla croce e alla croce del Signore Gesù.
A voi, Famiglie cristiane, chiedo la carità di non farci mancare la dimostrazione che non solo è possibile ma è bello vivere il vangelo dell’amore, nella fedeltà reciproca e nel più generoso servizio alla vita, ad ogni vita, soprattutto se povera e indifesa.
Ai Missionari, ai Laici cristiani impegnati nella catechesi, nella carità, nell’istruzione, nella nel lavoro, nella ricerca, nell’università, nelle istituzioni, nella comunicazione sociale; a quanti sono associati nell’Azione Cattolica, negli Scouts, o sono aggregati nella Fraternità di Comunione e Liberazione, nel Rinnovamento nello Spirito, nel Movimento dei Focolari, o in altre Associazioni, Movimenti, Gruppi o Comunità, come la grande Famiglia “Giovanni XXIII” e il Cammino Neocatecumenale: a voi e a quanti sarò lieto di conoscere e di incontrare, vorrei dire la mia gratitudine e ogni augurio di pace per il vostro servizio fecondo e la vostra insostituibile testimonianza, con l’invito pressante a guardare sempre al beato Alberto Marvelli e alla venerabile Carla Ronci, come modelli esemplari di vita cristiana.
Saluto con fraterno affetto la Parrocchia Ortodossa, la Comunità Evangelica Valdese e altre comunità cristiane. Inoltre saluto con sincero rispetto quanti appartengono a religioni non cristiane.
Rivolgo un pensiero fraterno agli Immigrati che cercano onestamente nuove opportunità di vita, di libertà e di lavoro nella nostra terra.
Per i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani prego il Signore che attraverso ognuno di voi voglia assicurare a tutti noi i doni incalcolabili delle varie stagioni della vita
Carissimi tutti, camminiamo insieme “nel nome del Padre…”!
Vi voglio bene e vi benedico di cuore
+ Francesco Lambiasi
Vescovo

















