DALLA PROFEZIA ALLA POLITICA DELLA PACE
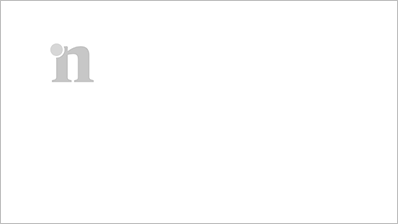
Il superamento del pacifismo etico
“L’intervento armato in Afganistan, che ha fatto seguito al tragico e cinico attacco terroristico dell’11 settembre, costituisce il quinto episodio di rilievo della “nuova epoca della guerra” che si è aperta con la fine della guerra fredda. Come sappiamo, la guerra è inscritta nell’evoluzione del genere umano; ma nel corso del tempo, essa ha mutato modi di intervento, ideologie, codici simbolici. Di questi mutamenti qui preme porre in risalto un aspetto: il superamento, oggi in atto, del pacifismo tradizionale, cioè del pacifismo etico. Nel corso del XX secolo, quest’ultimo ha assolto compiti fondamentali. Per un verso ha dato voce ai testimoni, spesso incompresi, del comandamento “non uccidere”, rappresentando un pungolo costante per l’azione politica riformatrice di molte istituzioni nazionali. Per l’altro verso, il pacifismo etico è valso a mostrare la sostanziale equivalenza pratica tra guerra e interventi di polizia internazionale. E infatti, perché ancora oggi c’è riluttanza a parlare di polizia internazionale piuttosto che di guerra? Perché la guerra, a differenza dell’intervento di polizia, è una sospensione della legalità, con il che l’attenzione al controllo di legalità passa in second’ordine. Inoltre, in azioni di polizia il principio di proporzione tra mezzi e fini è requisito indispensabile per il giudizio di responsabilità. Non così invece in guerra, dove la sproporzione è chiamata fatalità, inconveniente, disgrazia.
Il mondo migliora anche grazie alle utopie che pure non si realizzano pienamente. Questo è stato il pacifismo etico del XX secolo, che oggi non è più in grado, da solo, di far avanzare la causa della pace. Esso continuerà ad essere un’opzione della coscienza individuale, fondamentale e degna della massima tutela giuridica e della più ampia considerazione sociale; ma la pace in terra non verrà dalla sommatoria di tanti, speriamo tantissimi, obiettori di coscienza”.
Le ragioni della crisi
In base a cosa afferma ciò?
“Per due ragioni fondamentali. La prima è esterna al pacifismo: stanno mutando la natura e le cause della guerra, la quale non è ormai più tra macchine belliche statuali. Oggi, il dramma del pacifista etico è questo: sa che il suo rifiuto o la sua azione non difende l’intangibilità della vita umana contro la macchina di morte di un qualche Stato, ma si abbatte sul grido di aiuto del povero aggredito dal povero, della minoranza etnica massacrata dalla maggioranza, dei cittadini inermi uccisi o costretti a vivere in condizioni di endemica paura da organizzazioni terroristiche ben organizzate e ben finanziate. La seconda ragione è interna al pacifismo. Per quanto ci impegnassimo – e dobbiamo accrescere gli sforzi in tal senso – a far rifiorire il seme della pace nel cuore dell’uomo, non arriveremo a conseguire l’obiettivo fino a che non riusciremo a proteggere e ad irrobustire questo seme con solide istituzioni di pace, le quali non possono presupporre che già esista ciò che esse stesse devono aiutare a far venire alla luce.
Le istituzioni della pace
Se vuoi la pace prepara istituzioni di pace: questo è lo slogan del nuovo pacifismo istituzionale. Due i pilastri su cui esso poggia: primo, il riconoscimento della necessità e quindi l’istituzione di un potere reale di regolazione dei conflitti; secondo, la dislocazione sopranazionale (e non semplicemente internazionale) di questo potere.
Solamente se i diritti umani fondamentali troveranno la loro sede in un ordine giuridico democratico su scala mondiale – così come essi la trovano nelle nostre costituzioni nazionali – potremo ritenere che anche a livello globale i destinatari di quei diritti ne sono, al tempo stesso, gli autori. I diritti umani non vanno chiamati in causa unicamente come riferimento etico, come si continua purtroppo a fare, ma anche come riferimento giuridico. Le tappe per l’edificazione delle istituzioni della pace sono lunghe e piene di insidie. Ciononostante, è urgente compiere i primi passi con determinazione e speranza”.
Ripudio della guerra: nuove strategie
Cercando di tenere uno sguardo profetico e costruttivo al tempo stesso sul futuro, quali sono i possibili interventi e le possibili linee da seguire per poter affrontare le cause profonde del conflitto in corso?
“In primo luogo, il pacifismo istituzionale deve cominciare ad elaborare strategie e proposte in grado di produrre risultati concreti di limitazione degli eventi bellici, tenendo conto, in modo realistico e non utopico, dei vincoli di natura sia socio-culturale sia politico-economici. Concretamente, questo significa operare non solamente per l’educazione alla non violenza, ma anche per dare uno sbocco razionale al consenso morale verso l’uso qualificato della forza armata. Secondo, si tratta di rendere credibile il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. La credibilità, che è un patrimonio che richiede tempo per venire accumulato, si avvale della coerenza tra annunci e azioni e soprattutto dell’azione culturale tesa a convincere giovani e adulti che la guerra è sempre un gioco a somma negativa, nel quale tutti ci rimettono, alla fine.
Terzo, la credibilità del ripudio della guerra va basata su un principio alternativo a quello tradizionale della deterrenza. Come spiega R. Tamborini (2000), la dottrina della deterrenza consiste nella minaccia credibile verso l’aggressione potenziale. Invece, il ripudio della guerra viene costruito mediante la difesa credibile dell’aggredito potenziale. In altri termini, la prima si fonda sull’annuncio: ”se tu attacchi me o altri, io attacco te”; il secondo sull’annuncio: ”se tu attacchi qualcuno, io lo difenderò e dovrai attaccare anche me”. Il primo tipo di annuncio è quello che è ancora alla base del dispositivo di intervento della NATO; il secondo tipo di annuncio è implicito negli interventi degli ultimi anni di Giovanni Paolo II ed è contenuto nel principio di interposizione e peace keeping verso cui si stanno orientando le Nazioni Unite.
Dalla vendetta alla cultura del perdono
C’è però una sorta di precondizione che deve essere soddisfatta perché quanto sopra possa trovare uno spazio di concretizzazione: recuperare, a livello culturale, il significato pieno di perdonare, che significa etimologicamente ”donare completamente”. Ma cosa viene donato completamente? La vendetta ovvero il ”farsi giustizia”. La giustizia ottenuta con l’uso della forza, sia pure legittima, non è mai definitiva, né efficiente, perché il ”colpevole” non necessariamente si è pentito e quindi non espia la colpa. Il perdono, invece, è l’atto capace di obbligare il colpevole ad assumere la responsabilità del proprio gesto pentendosi ed offrendo alla società la propria espiazione – che deve esserci. E’ questo il livello più alto della giustizia, verso cui dobbiamo tendere. Ma è capace di perdonare solamente chi è capace di donare. Ecco perché è urgente ritornare ad insistere nelle nostre società sulla cultura del dono, espressione questa che negli ultimi decenni è stata addirittura espunta dal lessico comune. L’esempio più convincente per veicolare la cultura del dono è, oggi, quello dell’economia del dono”.

Dopo l’11 settembre niente più strabismo
Sembra che gli avvenimenti dell’11 settembre abbiano determinato un evidente cambiamento nella politica statunitense, in particolare un diverso atteggiamento nei confronti del fenomeno della “globalizzazione”. Ci sono dunque delle interrelazioni e delle influenze reciproche tra il perseguimento della pace e le possibili scelte di politica economica e internazionale?
“L’11 settembre, gli USA hanno scoperto l’inclusione del proprio territorio in quello stesso spazio globale che essi avevano contribuito in gran misura a costruire. E’ questo il dato nuovo. Fino all’11 settembre gli USA (e in generale l’Occidente) guardavano alla globalizzazione con sguardo doppio: lavoravano alla trasformazione del pianeta in un unico spazio interdipendente, ma al tempo stesso se ne consideravano ”fuori” e ”sopra” e dunque invulnerabili alle spinte distruttive che proprio il processo di globalizzazione andava generando. Gli USA hanno continuato a credere, fino all’11 settembre, di poter restare protetti dalla distanza: prendere dalla globalizzazione i vantaggi che essa genera e non sopportarne i costi relativi. Eppure, non c’è economista al mondo che non sappia che là dove ci sono benefici, vi sono anche costi!
Le prime conseguenze
Le conseguenze del devastante shock sul comportamento e sulla cultura dei cittadini americani già si cominciano a vedere. a) La politica estera americana sarà meno isolazionista. L’esperienza della coalizione anti-terrorismo avrà effetti duraturi. Gli USA hanno finalmente pagato una buona parte del loro debito nei confronti dell’ONU. Anche l’unilateralismo verrà rivisto. Un esempio concreto lo si è visto al recente vertice di Marrakesh nei confronti dell’accordo di Kyoto.
L’economia della paura
b) La potenza economica e militare non sarà più garanzia di sicurezza, come era stato vero finora. Ma sappiamo che senza sicurezza, le società non sono in grado di godere dei frutti degli aumenti di reddito e di ricchezza. E’ questa una contraddizione affatto nuova, da cui nasce quella che P. Krugman ha chiamato l’economia della paura. A che serve produrre quantità crescenti di beni e servizi se poi l’insicurezza (che è cosa ben diversa dal rischio) non ci consente di goderne?
c) Negli ultimi anni, il pensiero unico aveva fatto credere che il neoliberismo sarebbe stato l’ideologia del futuro. Il presupposto centrale di tale ideologia è che la politica possa essere rimpiazzata dall’economia e lo Stato dal mercato. Questa concettualizzazione regge fin tanto che della globalizzazione si possono incassare i soli risultati positivi. L’11 settembre ha posto il pensiero neoliberista profondamente in discussione. Dobbiamo aspettarci un ritorno della politica, ma in forme nuove. Non più nella forma dello Stato-nazione, ma in quella di un nuovo sistema di cooperazione transnazionale, in cui il destino economico e sociale dei singoli paesi non può essere più ignorato e trattato strumentalmente.
È iniziata l’era post-global
Da quanto afferma, quali congetture sul futuro è possibile ricavare? “Primo, non ci sarà una palingenesi della globalizzazione americana degli anni ’90. Si può dire che l’11 settembre ha accelerato il passaggio dall’era global all’era post-global. Ad esempio, non sarà più possibile per P.O’Neill, ministro del Tesoro USA, rifiutare l’accordo OCSE sul riciclaggio del danaro sporco. Le piazze bancarie off-shore non sono nate per caso. Esistono perché Wall Street e le altre Borse volevano dei paradisi fiscali. C’è stata un’ipocrisia bipartisan: mentre gli USA chiedevano trasparenza sui mercati emergenti in conseguenza della crisi dell’Est Asiatico, L.Summers (ministro del Tesoro dell’amministrazione Clinton) e O’Neill hanno unito le loro forze per proteggere le piazze bancarie off-shore e i fondi di copertura.
Nascerà un Fondo di sviluppo?
Secondo, si arriverà ad una ridefinizione delle regole che governano i movimenti speculativi dei capitali. Una volta preso atto che la fonte principale di finanziamento dei gruppi terroristici è costituita dalle piazze finanziarie, si proporrà di introdurre qualcosa di simile alla “Tobin tax” (ma non verrà certo utilizzata tale espressione!) per costituire un “Fondo per lo sviluppo” gestito da un’Agenzia internazionale appositamente costituita. Una cosa impensabile fino a ieri, sul sistema finanziario sono scesi controlli, freni, rigidità da sempre considerati nemici della libertà di movimento. Altro che Tobin tax!
Terzo, la riunione ministeriale di Doha della WTO si è conclusa nei giorni scorsi con l’impegno a lanciare un nuovo round commerciale per segnalare la volontà dei paesi ricchi di rispettare la volontà di quelli poveri di trovare nuove regole che consentano agli esportatori dei paesi in via di sviluppo e in transizione un maggior accesso ai mercati dei paesi ricchi (soprattutto nel settore dell’agricoltura e delle attrezzature industriali) e regole più giuste per il diritto di proprietà intellettuale. Si tenga presente che i paesi avanzati spendono circa 350 miliardi di dollari all’anno per sostenere i loro agricoltori!
La riduzione delle barriere commerciali
L’esito del vertice non era affatto scontato; anzi le previsioni erano piuttosto negative. Invece, a dispetto delle varie Cassandre, due risultati importanti, sia pure parziali e ancora insufficienti, sono stati raggiunti. Il primo è che si è definitivamente passati – dopo alcuni decenni di accesi dibattiti – dal principio “ti aiuto, ma proteggo i miei mercati” al principio “ti aiuto ad entrare nei miei mercati”. Un recente studio del Tinbergen Institute di Rotterdam ha stimato che l’aumento del reddito per i paesi poveri che deriverebbe da una riduzione delle barriere commerciali del 20% sarebbe pari a 59 Mld di dollari, di gran lunga superiore ai 42 Mld di dollari di aiuti (assistenzialistici) alla sviluppo concessi negli anni 1995-98. Il secondo risultato importante è l’accoglimento (finalmente!) del principio secondo cui non tutti i PVS sono eguali e dunque che le strategie di sviluppo non possono essere le stesse per tutte le realtà. Come si può comprendere, un principio del genere apre le porte all’applicazione pratica, su scala globale, di quel principio di sussidiarietà che finora è stato limitato al livello nazionale o, al più, regionale.
Il compito del cristiano è nella storia
E’ certo che ancora molto resti da fare per invertire la tendenza di questa nuova età di disuguaglianze che è magna pars nella spiegazione dei conflitti attuali. Un solo dato curioso: oggi si spendono molte più risorse finanziarie e umane per studiare nuovi cosmetici che per curare le malattie tropicali e le cosiddette “malattie orfane”. Ma il cristiano non può indulgere nella tentazione di restare al di sopra della realtà con l’utopia, né collocarsi al di sotto della realtà con la rassegnazione. In entrambi i casi, ci sarebbe posto solo per la disperazione. Sappiamo, invece, che è proprio nelle fasi di forte crisi, come è quella attuale, che si aprono spazi inattesi per l’irruzione nella storia del “messaggio della salvezza”.
Maurizio Mussoni

















